Alla ricerca della custodia perduta del creato: attualità scottante nei due libri di Cristina Morra da presentare venerdì 25 nella Sala di Rappresentanza del Comune
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Sono due libri di Geografia storica, ma sanno aprire suggestive finestre oltre la storia e la geografia, “Il pianeta squilibrato” e “L’agricoltura nel mondo”, i due libri della Prof. Cristina Morra, docente di Geografia e Formatrice Didattica, originaria di Napoli e residente ad Arezzo, che saranno presentati venerdì 25 settembre p.v. , alle 17,30, nella manifestazione Alla ricerca della custodia del creato perduta – Riflessioni attive su una sostenibilità socioambientale, presso l’artistica Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni, con la presenza della stessa autrice e la relazione del Prof. Vincenzo Aversano, docente dell’Università di Salerno.
Con efficace essenzialità, e pur senza avvalersi degli effetti speciali offerti dalla grafica moderna, essi infatti, volando dalle tracce del passato fino alle incognite del “Futuro di noi tutti”, si sanno trasformare in un fascinoso romanzo dell’Uomo (ora solidale, più spesso lupo verso i suoi simili) e del suo rapporto con la Terra, del suo primitivo rispetto d’amore per la Terra, delle sue controverse scelte contro la Terra.
E, grazie all’uniformità della scrittura ed alle connessioni delle tematiche, sono di fatto due volumi in un’anima sola.
La prof. Morra unisce in sé sia la competenza del docente ad alto tasso di comunicazione, sia la profonda cultura di una persona che ha affidato ai libri (e ai viaggi) una parte sostanziosa del proprio kit di benessere, sia una plusvalente e prestigiosa autorevolezza che le ha fatto a suo tempo meritare la convocazione nella Commissione Nazionale Brocca per la Riforma della scuola. Su queste basi, nella sua Geovisione complessiva lei riesce in ogni capitolo a non perdere mai di vista il filo base: i rapporti tra uomo e ambiente, la capacità dell’Uomo di scrivere la firma del suo passaggio nel paesaggio, la gestione distributiva delle risorse, che fin dagli albori, dai primi scontri tra nomadi pastori e agricoltori stanziali (forse tanti Caino e Abele), ha generato e genera conflitti , violenze e disuguaglianze tra ceti sociali, comunità, popoli.
Questa storia lei la racconta con una chiarezza di linguaggio, pregnanza di sintesi e profondità di contenuti, illuminanti per il colto ed accessibili anche per il (quasi) inclito. Se si ha la pazienza della lettura allo stato puro di libri fatti al novantacinque per cento di parole (senza chiedere, come si fa spesso oggi, soprattutto la brevità superficiale ed il supporto delle immagini), ci si accorgerà che in tematiche scottanti come queste la Morra ci fa da cicerona perfetta, preoccupandosi, da docente qual è, di offrire, per ogni argomento o argomentazione, “prima il pane e poi il caviale”. Tiene cioè a spiegare innanzitutto di cosa stiamo parlando, attraverso definizioni, individuazione a schema dei nodi principali, argomentazioni che procedono cartesianamente per concetti chiari e distinti e sempre, sfruttando con valore aggiunto la mentalità giornalistica, mette in primo piano il concetto da evidenziare.
Rispetto alla trattazione pura e semplice, poi, con giusta furbizia comunicativa, inserisce gustosi e più distensivi capitoletti che raccontano realtà particolari, come lo shabono degli Yamamani (il villaggetto a circolo), l’utilizzo totale dello yak tibetano (un animale di cui, come nel nostro maiale non si butta niente), le soluzioni ecologiche ed energetiche della Danimarca, l’importanza strategica e rivoluzionaria della Tobin tax (la tassa sui mercati finanziari), la pittoresca produttività dei microfondi costieri (e noi ne sappiamo qualcosa), e via dicendo.
Anche questi a argomenti, però, non scivolano mai fuori dal filo conduttore di cui abbiamo parlato.
Un filo che parte dalla nascita rigeneratrice dell’agricoltura stanziale, successiva allo sfruttamento “a bruciature” dell’agricoltura itinerante e della coltivazione a debbio (che già era un progresso rispetto alla selvaticità dei primi uomini). Un filo che porta fino ai rischi contemporanei delle monoculture, delle piantagioni, della rivoluzione verde imbevuta però di additivi chimici e ambigue infiltrazioni transgeniche. Un filo che denuncia la progressiva perdita di identità del locale di fronte alle esigenze produttive del globale, che se significa alta comunicazione significa anche altissimi investimenti che richiedono un ritorno di profitto e quindi tendono a schiacciare le esigenze di comunità e di persone.
Questo filo ci fa viaggiare dalle origini dell’agricoltura, quando, sia pure con grande sforzo, l’equilibrio tra colture e necessità del posto riusciva a dare uno sbocco importante alle esigenze alimentari, ai paradossi dell’agricoltura contemporanea, in cui, a fronte di raccolti anche record, i prezzi dei cereali di base anziché diminuire spesso aumentano, perché comunque il raccolto è inferiore al fabbisogno reale e la gestione commerciale dei mercati aumenta disuguaglianze e sottosviluppo e la distanza tra popoli ricchi e popoli in difficoltà. E invece, se si rispettassero le esigenze reali delle collettività e soprattutto se la terra non fosse prosciugata o desertificata da politiche scellerate, il raccolto potrebbe garantire il presente ed il futuro. Invece, come denuncia con forza la Morra, per produrre di più oggi, siamo esposti al rischio averne meno domani.
Questo filo ci porta a viaggiare nell’interno del Sistema Mondo ed a farci vedere con lucidità tutti i principali problemi planetari, come le risorse in esaurimento, le fonti energetiche sufficienti solo a breve termine, le tante e letali forme di inquinamento, i pericoli della deforestazione, l’effetto serra, la mancanza di equità nei rapporti tra i popoli e, ancora più rischiosa, di equità tra generazioni.
E prova anche a suggerire delle soluzioni, che sarebbero del resto già note e praticabili se non cozzassero contro interessi ben definiti. Tra queste, segnaliamo , a livello agricolo, l’eliminazione dei latifondi e delle monocolture, con il sostegno alla piccola proprietà ed alle coltivazioni legate alle esigenze del territorio. Aggiungiamo anche una commercializzazione dei prodotti agricoli in cui non ci sia una forbice così elevata tra il ricavo del produttore (pochissimo) e quello del venditore finale (elevatissimo). In altro campo, sappiamo bene che lo strapotere della finanza e dell’economia più virtuale che reale non produce alcun benessere diffuso e che i monopoli delle tecnologie creano dipendenze politiche. E via dicendo. E non ci inoltriamo oltre, altrimenti corriamo il rischio di aumentare l’ammasso dei grovigli e la possibile comprensione del Sistema Mondo.
Ma non è solo questione di comprensione. È questione di scelte. E bene ha fatto la prof. Morra a darci gli strumenti per navigare senza disperderci nei suoi labirinti. Strumenti che sono in linea con atteggiamenti propositivi che, a livello globale, vengono anche da più parti. Dall’ONU, per esempio, che però incide ben poco sugli equilibri politici e militari. O da eventi come l’EXPO, che non a caso ha posto come tema proprio il problema dell’alimentazione mondiale, presente e futura (e i due padiglioni chiave in questo senso, il Padiglione zero e lo Slow Food, sono illuminanti dell’anima della manifestazione).
Una spinta importante, forse decisiva a livello globale, può anche venire dall’opportuna, felice e inequivoca insistenza, di fatti, segni e parole, con cui l’attuale Pontificato (vedi la recente enciclica, a cui si richiama esplicitamente il titolo della manifestazione) sta ponendo sul piatto tanti di questi problemi, non a caso scatenando anche reazioni ostili dei tanti farisei e dei potenti che si sentono minacciati e che preferiscono i segni del potere al potere dei segni.
Insomma, stiamo nel vivo del cuore del Mondo. Anche per questo batte così forte nella mente cuore della prof. Morra e quello dei suoi libri di geovisioni .
È un contributo significativo al processo di educazione, anzi di rieducazione delle nostre generazioni sconsideratamente moderne, perché si riattui realmente la sacrosanta custodia del creato, che è la più vera e amata e amabile Cosa Nostra. E soprattutto perché la globalizzazione della società non si trasformi, come teme Papa Francesco, in un’arida e desertificante globalizzazione dell’indifferenza.
- Locandina Alla Ricerca della Custodia del Creato
- Il logo del giorno della custodia del creato
- Paesaggio con disuguaglianza
- Vincenzo Aversano
- Cristina Morra
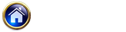





Commenti non possibili