CAVA DE’ TIRRENI (SA). La Lucania “profonda”e la sua scoperta attraverso il cinema in un bel saggio della cavese Gabriella Avagliano
Nell’anno di Matera Capitale della Cultura e dei riflettori mediatici sul suo territorio, è opportuno e benvenuto il saggio Tracce del Mezzogiorno nel documentario etnografco – Cultura popolare e trasformazioni sociali in Lucania (1958 – 1971) – Edizioni Area blu, opera prima di Gabriella Avagliano, cavese doc. È una tesi di dottorato, realizzata nel 2015 con la guida del Prof. Pasquale Iaccio, poi adattata a volume autonomo. Operazione sacrosanta, perché i lavori prodotti per titoli di laurea rimangono negli archivi, mentre un libro diventa patrimonio della società.
E questo libro è ricco e stimolante, sia perché offre un panorama completo della produzione filmica relativa alla Lucania e di riflesso al Mezzogiorno, sia perché, nonostante la scientificità della ricerca, non è freddamente nozionistico, ma con una narrazione chiara e coinvolgente offre un viaggio emozionato ed emozionante nella scoperta e riscoperta di un mondo ancora troppo ignorato.
Nello stesso tempo, il saggio mette un punto fermo sull’importanza che in tutto il Novecento ha avuto l’immagine filmica nella conoscenza della cultura e delle tradizioni popolari. Lo studio non si ferma all’immagine, ma la analizza e l’approfondisce fondendo in un’organica sinergia la storia, l’antropologia, la cinematografia, ai fini di uno studio etnografico e non semplicemente folklorico, per recuperare e far conoscere le radici identitarie di tutta una comunità.
È la ripresa di un processo di scoperta che in Italia, in un Regno nuovo composto da territori e popolazioni diversi e ben poco conosciuti, aveva già caratterizzato l’attività intellettuale subito dopo l’Unità, con il realismo letterario dei vari Verga, Capuana, De Marchi &Co., .
Quello che una volta poteva essere fatto dal libro, nel Novecento è stato fatto dal cinema e dal documentario, che però solo in tempi recenti sono stati finalmente considerati fonti basilari per la conoscenza scientifica di una comunità. Se il cinema in questo senso ha avuto una notevole diffusione anche popolare (vedi il Neorealismo del secondo dopoguerra e i suoi epigoni più o meno fedeli), il documentario è rimasto sempre un po’ ai margini, anche quando veniva collegato alle proiezioni nelle sale e di fatto “sopportato” più che amato da un pubblico in cerca di “finzione”.
Fedele all’assunto di inquadrare ogni contenuto in una cornice di più ampio respiro, la Avagliano apre il saggio proprio con una storia del documentario, dalle origini del primo Novecento all’epoca del grande boom italiano e del passaggio da una cultura rurale ad una industriale.
Il viaggio parte dal primo Novecento, mostrandoci subito le contraddizioni politiche che il documentario genera, perché, se fatto per committenza governativa, diventa propaganda, ma se fatto con spirito giornalistico diventa una pericolosa alternativa alla voglia del potere di non mostrare i panni sporchi. Al riguardo, la Avagliano ci fa notare che poi si è sviluppata, pur in tempi più tolleranti, la censura economico-politica, che sosteneva con somme di danaro non i documentari più belli ed efficaci, ma quelli che incassavano di più o che erano segnalati da un’apposita Commissione, dove clientelismo e opportunismo la facevano da padroni.
In questo viaggio non si poteva non citare la produzione della Dora film di Napoli, dove spicca la figura della prima regista donna del cinema italiano, Elvira Notari (con ascendenze cavesi e scomparsa a Cava de’ Tirreni, nella sua casa di via Formosa). Anche la Dora si ritrovò con le spalle al muro perché la realtà napoletana, con tutto il suo corredo di storie di violenza, povertà e malavita, era in epoca fascista proprio la cenere da mettere sotto il tappeto.
Per fortuna, il dopoguerra e la costruzione della nuova Italia repubblicana hanno poi rilanciato l’attenzione sulla realtà, a volte anche sgradevole, dei problemi sociali e della cultura autonoma delle masse popolari. Ed è stata scoperta, quasi come un’isola indigena, la Lucania, con le sue tradizioni arcaiche, la sua visione magico-religiosa del mondo e la sua secolare povertà., divulgate allora alla grande dal successo di Cristo si è fermato a Eboli e dalla “pubblicizzazione” dei Sassi di Matera e della scarsissima qualità della vita di chi ci abitava. Pur senza mai dimenticare la cornice del Mezzogiorno nel suo complesso, proprio sul cuore della realtà lucana si focalizza l’attenzione della Avagliano, che con fotografie e brevi schede ci presenta l’opera meritoria dei grandi documentaristi del Novecento, dal capostipite Ernesto De Martino ai suoi seguaci, in primis Gandin, Del Fra e il compianto Di Gianni, da poco scomparso ed al quale la stessa autrice dedica alla fine del saggio un’intervista ricca di spunti umani, oltre che scientifici.
Proprio i documentari relativi ai riti e alle credenze arcaiche sono la parte più “spettacolare”, ricca di tappe fascinose … I lamenti funebri con le loro teatralizzazioni che erano anche condivisione comunitaria di un fatto e di un’emozione … il taglio delle nuvole per esorcizzare il pericolo sempre incombente dei disastri climatico … la miseria dei Maciari… il colloquio con l’al di là nella possessione di sua zia da parte del “Glorioso Alberto”… il rito coreutico del gioco della falce, a corredo della coltivazione dei campi …. la svestizione del padrone, di tipo carnevalesco, che esprimeva la rabbia atavica dei contadini contro la proprietà, ma nello stesso tempo era uno sfogo non violento e per questo tollerato (Meglio questo che Spartaco, si diceva …) … il rito d’amore dell’inceppata, con il ceppo dello sposo posto davanti alla casa della sposa e da questa portato in casa, segno di legame affettivo ma anche preannuncio di fatiche … il rapimento della sposa nel rito matrimoniale degli Albanesi … il culto mariano, anche un po’ pagano, con gli esempio eclatanti della Madonna di Pierno e di quella del Pollino.
Il tutto è rappresentato in chiavi diverse a seconda della personalità del documentarista e della sua capacità, o volontà, di oggettivarsi nell’immagine: ora il giusto campo lungo che accomuna persone e ambiente, ora il particolare della mano o del volto che esprime una sensazione o un’interpretazione, ora la musica che connota il misterioso, ora il realismo freddo, ora la scelta del particolare più “negativo” capace di bucare il video e dare il messaggio senza mezze tinte.
La ricerca del mondo arcaico assume poi un sapore diverso quando col passare degli anni l’attenzione si sposta sulle novità del boom economico e sullo svuotamento delle comunità del Mezzogiorno, in particolare della Lucania, con un tasso di emigrazione interna verso il Nord industrializzato che lascia nei paesi solo anziani e poche anime di buona volontà.
Alla svolta epocale del passaggio dalla società rurale a quella industriale la Avagliano dedica un buon terzo del saggio, realizzando una carrellata che, se da un lato rivela meno la partecipazione emozionale alla magia, dall’altra presenta interessantissime informazioni sulla gestione mediatica dell’industrializzazione. Le industrie e il governo commissionano moltissimi documentari, per propagandare le trasformazioni radicali che si stanno effettuando nella società italiana, le strutture produttive, le bonifiche, le urbanizzazioni, la nascita di nuovi quartieri e di abitazioni più confortevoli, la lotta all’analfabetismo. Fioriscono non solo documentari, ma anche tanti film e naturalmente si incentivano i talenti, compresi i grandi registi, come Ivens e Lizzani, che, pur non nascondendo i benefici della società industriale, non possono fare a meno di evidenziare anche i problemi di questa “modernità liquida”, come, citando Bauman, la definiva Luigi Di Gianni, che è in fondo il convitato di pietra di tutto il saggio. E, nel cinema, non dimentichiamo gli altri grandi, come Antonioni, Olmi, Lattuada e soprattutto Visconti, autore di quel capolavoro epocale che è Rocco e i suoi fratelli, epopea di una famiglia lucana nella Milano industriale.
Belle le due finestre finali del libro, che l’autrice sembra sentire più suoi, per il calore sottinteso che emana dagli esempi portati avanti in rapporto ai singoli documentari. La Avagliano mette molto in evidenza il ruolo della donna in questa convulsa fase di crescita. Era diventata la dea ex machina di tante situazioni difficili: oltre alle mansioni abituali, doveva ricoprire il ruolo del marito emigrante, adeguarsi ai ritmi della modernità in rapporto ai figli e alle loro esigenze, entrare lei stessa nel mondo del lavoro … del resto, lo sappiamo, il mondo è pieno di donne che hanno fatto la storia ….
La stessa cosa vale per l’intervista a Luigi Di Gianni poco tempo prima della sua morte. L’incontro è stato quasi filiale, ma nello stesso tempo, svelando alla Avagliano i meccanismi del suo lavoro di ricerca e di creatività e i retroscena umani ad essi sottesi, Di Gianni la lancia col cuore verso un mondo in cui comunque non si può fare a meno della ragione.
Alla fine, nonostante la logica imperante del linguaggio di ricerca, la lettura finisce col risultare sempre piacevole e interessante, come quella di un bel romanzo. E nel cuore della Lucania, del Mezzogiorno e del loro ribollente secondo Novecento ci entriamo anche noi. Vuol dire che la Avagliano ha saputo proprio accenderla, quella fiammella …
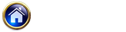


Commenti non possibili