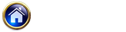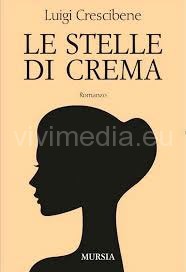Archivio
ricerca per autore
Pippo Zarrella “avanza” ancora: terzo al Concorso di Duino. Ha presentato un testo ispirato allo sbarco su Lampedusa di un immigrato e di uno yacht man
 CAVA DE’ TIRRENI (SA). È un concorso incentrato sull’incontro fecondo e stimolante tra Creatività e Solidarietà, è è considerato dall’UNESCO uno dei più importanti concorsi del mondo riservati ai giovani: è il Concorso Internazionale di Poesia di Duino (Trieste), patrocinato tra l’altro dal Presidente della Repubblica e dal principe Della Torre e Tasso del Castello di Duino.
CAVA DE’ TIRRENI (SA). È un concorso incentrato sull’incontro fecondo e stimolante tra Creatività e Solidarietà, è è considerato dall’UNESCO uno dei più importanti concorsi del mondo riservati ai giovani: è il Concorso Internazionale di Poesia di Duino (Trieste), patrocinato tra l’altro dal Presidente della Repubblica e dal principe Della Torre e Tasso del Castello di Duino.
Sul podio assoluto di quest’anno c’era anche il cavese Giuseppe (Pippo) Zarrella, che si è classificato terzo nella sezione Teatro con un pezzo intitolato Sbarco tu che sbarco anch’io, che, in montaggio alternato e con il racconto in prima persona da parte dei due protagonisti, presenta provocatoriamente le diverse angolazioni di vita di uno snob ricco di soldi e di un extracomunitario che separatamente si avviano allo sbarco a Lampedusa, uno su uno yacht e l’altro su un barcone.
Alla fine nel cuore del lettore sbarcano tanta amarezza, uno schizzo di rabbia, ma anche un sorriso rinfrescante prodotto dallo stile di Zarrella, che, sulla scia dei pluripremiati racconti del plurivenduto e plurirappresentato Avanzi, ha la sensibilità ed il coraggio della denuncia sociale e del viaggio nel cuore degli ultimi, ma anche l’abile intelligenza della leggerezza narrativa e della fantasia immaginativa, che coinvolgono il lettore e generano comunque speranze di un cambiamento.
Questo è stato notato, almeno in parte, anche dalla Commissione Giudicatrice del premio, che ha formulato la seguente motivazione: Con semplicità ed ironia il giovane Zarrella è riuscito a dipingere il tema dell’immigrazione, creando a tinte forti un dialogo muto tra i due protagonisti, i quali, “sbarcando” entrambi sull’isola di Lampedusa, hanno in comune molto di più di quello che si possa immaginare. Il tutto incastonato in una litania infantile che dona spessore all’intera composizione.
Il riconoscimento non si è fermato alla consegna del premio, il 23 marzo scorso, ma continuerà con la pubblicazione dei testi vincitori in un libro bilingue con allegato un CD contenente la recitazione degli stessi nelle lingue originali, il cui ricavato sarà devoluto dalla casa Editrice Ibiskos che lo pubblicherò, alla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin per i bambini vittime delle guerre. Insomma, una piccola, ma significativa catena di solidarietà.
Intanto Pippo non si fermerà, ma continuerà ad avanzare con i suoi Avanzi, che, messi artisticamente in scena dal magnifico Antonello De Rosa e da un gruppo di giovani attori, saranno rappresentati in alcune rassegne estive.
E chissà che, intanto, il buon Pippo non stia avanzando nel concepimento e/o nel parto del suo secondo libro, per tatuare ancora meglio il suo nome nello scenario culturale cittadino e, soprattutto, oltre le mura di Cava. Sarebbe questo, per lui lo “sbarco” più importante…
Il gran ritorno di Manuel Foresta: il cantante cavese aprirà i concerti di Renzo Rubino e il 18 aprile canterà al Pub “Il Moro”
 CAVA DE’ TIRRENI (SA). Dopo aver cominciato a studiare musica e produrre canto nella natia Cava de’Tirreni sotto la guida del Maestro Michelangelo Maio, dopo aver sfiorato la vittoria nella prima edizione di The voice, il talent show RAI di Raffaella Carrà, dopo essere stato molto vicino all’ammissione al Festival di Sanremo 2014 (vicino quest’anno, dentro il prossimo?), il nostro Manuel Foresta continua la sua scalata al Monte Successo con una campagna di primavera già riscaldata da tre appuntamenti a fuoco vivo.
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Dopo aver cominciato a studiare musica e produrre canto nella natia Cava de’Tirreni sotto la guida del Maestro Michelangelo Maio, dopo aver sfiorato la vittoria nella prima edizione di The voice, il talent show RAI di Raffaella Carrà, dopo essere stato molto vicino all’ammissione al Festival di Sanremo 2014 (vicino quest’anno, dentro il prossimo?), il nostro Manuel Foresta continua la sua scalata al Monte Successo con una campagna di primavera già riscaldata da tre appuntamenti a fuoco vivo.
Il 18 aprile, tornerà nella sua Cava con la band ed uno spettacolo tutto suo. Luogo dell’incontro: il pub “Il Moro”, che immaginiamo sarà gremitissimo di amici e fans, pronti ad applaudire con affetto ed ammirazione la sua flessuosa presenza danzante in voce scenica. E non sarà proprio un Déjà vu, ma un grande ritorno per una scattante ripartenza…
Prima e dopo, alla grande con un neobig della Musica Italiana. Il 14 aprile al Teatro Bellini di Napoli ed il 6 maggio al Modo di Salerno aprirà i concerti di Renzo Rubino, il giovane cantante pugliese che al Festival di Sanremo lo scorso anno ha vinto il premio Mia Martini della Critica e quest’anno il premio per il miglior arrangiamento nella Sezione Campioni. Un cantante che fa della qualità, della grinta e dell’espressività il segno di ogni sua esibizione.
Roba da Manuel, insomma, degno banderillero del matador Rubino, ma già pronto ad essere al più presto lui, il Matador…
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Antonello De Rosa, corpo di scena nella scena dell’anima. “Tracce di mamma” e “Jennifer” alla Rassegna “Licurti”: e si accende il fuoco del Teatro
Ha volato alto, Geltrude Barba, Direttrice artistica del Teatro Luca Barba e Direttrice Artistica della Rassegna Licurti, in scena al Social Tennis di Cava de’ Tirreni da ottobre ad aprile.
Due appuntamenti nel giro di un mese, due opere entrambe elaborate da testi di Annibale Ruccello.Traccia di Mamma, ispirato a Mamme, figure e storie di donne a contatto con le luci e le ombre della maternità vissuta e/o vagheggiata, è andato in scena il 21 in una serata dedicata all’Associazione Onlus O.A.S.I. di Nocera Inferiore (assistenza sanitaria e ludico ricreativa verso i bambini ospedalizzati dell’Umberto I di Nocera Inferiore), di cui è madrina la presentatrice Carmela Novaldi.
Jennifer, ispirato a Le cinque rose di Jennifer, andato in scena il 16 marzo, è la storia di un travestito che attende in un chiaroscurale saliscendi di umori ed illusioni la telefonata dell’uomo amato, una telefonata che si fa attendere invano e che (forse) arriva quando è troppo tardi.
Due drammi scritti per dialoghi e, soprattutto il primo, trasformati in monologhi ora formali ora sostanziali. Due opere un unico regista ed attore, il salernitano Antonello De Rosa.
E tutta la rassegna Licurti si è colorata di Teatro con la T maiuscola.
De Rosa il teatro lo vive e lo fa vivere dal profondo delle viscere e carezza lo spettatore con scene e recitazione avvolgenti, ma nello stesso tempo lo scuote a cazzotti con la provocazione dei contenuti e dei gesti, impostati con una proposta scenica tanto incisiva da non poter essere rifiutata neppure da chi è abituato ad altri linguaggi più conformisticamente ortodossi, perché la creazione di empatica umanità è così vera da spingere piuttosto a chiedersi come e perché da certi tipi di emozioni finora ci si sia difesi, anziché nuotarci dentro come si fa con ogni onda di vita che ci accoglie.
Un teatro di pancia, quindi? Solo nella parte che gli compete. Antonello De Rosa non se lo perdonerebbe, perché quell’istinto che violento ruggisce nei suoi gesti e nelle sue parole per essere efficace deve comunque essere incanalato dalla ragione, che nel nostro caso sono le demiurgiche scelte del registache si fa attore e recita facendosi autore, in una triade che, concentrandosi in una sola persona, ha necessariamente bisogno di saldi fili da burattinaio.
Teatro tradizionale, allora? Solo per quel filo identitario che lo lega all’autore del testo di partenza ed alle radici di una storia di culture e di espressioni che radicate nei decenni e nei secoli. Il che non è poco. Ma su questo De Rosa innesta il vortice della sua creatività visiva ed interpretativa. Un vortice con punti ben fermi e decisi.
Innanzitutto, l’uso del corpo e della sessualità di genere.
Antonello De Rosa a teatro non ha un corpo, ma è un corpo. Come del resto siamo o dovremmo essere tutti, mentre invece siamo portati a distinguere l’io dal resto. E non diciamo che è un corpo perché egli si mostra con assoluta e pari disinvoltura sia con i vestiti sia senza: sarebbe troppo banale. Egli “è” un corpo perché ogni gesto, ogni parola, ogni movimento, ogni suono, ogni produzione dei sensi, ogni pensiero vivono insieme e comunicano insieme in armonica sinergia.
Non sentiamo il bisogno di concentrarci sul primo piano del volto, come nel teatro o nella ripresa tradizionale. Ma non veniamo neppure inondati da movimenti ridondanti e scomposti o dissociati dalla parola, come a volte succede nel teatro gestuale moderno.
Potremmo dire, scomponendo scherzosamente il buon Totò, che è il totale che fa la somma. Questo succede sia che Antonello rimanga statuariamente immobile con un manto rosso strascicato e lunghissimo, come in Tracce di mamma, sia che passeggi per la sala con una coloratissime vestaglie a polpaccio a spacchi intermittenti, come in Jennifer, sia che parli in slip o in sottoveste o mentre si trucca, sia che se ne stia seduto semplicemente a “diamonologare” col pubblico o al telefono o con un interlocutore più o meno presente in scena, come è avvenuto in tutte e due le pièce.
La magia del teatro e la sua abilità attoriale, farcita ora da silenzi sgomenti o perplessi (straordinario il lungo silenzio parlante della mamma sbigottita per la precoce gravidanza della figlia), ora da sguaiatezze espressive, ora da esplosioni emotive ora da calibrati spifferi di inferni e insicurezze interiori, fanno sì che parole, gesti, movimenti e suoni prima siano contorno ad un corpo composto di efebiche levigatezze, sorprendenti rotondità, barba da macho e voce politonale, e poi cedano il posto ad un insieme in cui quel corpo è prima di tutto persona, colta nella sua più deflagrante umanità.
Tutto questo mette in secondo piano il fatto che un uomo, come in Tracce di mamma, inglobi quattro parti di donne in una sola figura femminile (del resto il teatro è nato senza attori di sesso femminile…) ed in Jennifer crei, oltre le stesse intenzioni originarie dell’autore Ruccello, una figura che può essere indistintamente un travestito o una donna oppure un gay, perché è semplicemente una persona che vive ai margini in una società dove comunque si consumano delitti contro gli emarginati, una persona innamorata di un’altra persona, una persona sola che gioca come il gatto col topo con i morsi della solitudine.
Quanto detto in rapporto al corpo, vale anche per la scenografia e l’atmosfera, che nella regia di De Rosa fanno corpo con il corpo e l’anima dell’attore..
In entrambe emerge il colore rosso dell’energia vitale, rappresentato in Traccia di mamma dal lungo manto rosso occupato dai agli orli dai santini, in Jennifer dal vestito della donna allo specchio anima-tempo-passione. E prevalgono la penombra e la luce soffusa, non solo per creare la suggestione giusta per il feeling tra il pubblico tutt’intorno e la magica ed inquieta sinergiacorpo-animadell’attore-personaggio-persona, ma anche per evidenziare la dimensione mistero, la linea spesso indefinibile tra immaginazione e realtà, tra la consolazione del vagheggiamento e i pungenti schiaffi della concretezza.
Così in Traccia i sogni della donna si concentrano, in un poetico conflitto ideale-reale, sull’immaginazione dettata dai vagheggiamenti personali o dai media o dalle leggende religiose, e l’istinto della donna mamma si scontra ora con la prigione, mentale prima che fisica, del bigottistico convento di suore, ora con l’esplosione di sottile ferocia materna di una madre che non accetta il “disonore” della figlia-figliola incinta e la spinge più o meno consapevolmente al suicidio. E in Jennifer il desiderio di essere chiamata al telefono dalla persona amata si scontra con le risposte di voci non cercate eppure in quel momento amate pur di aprire una relazione almeno momentanea.
In effetti, il nodo centrale per De Rosa è l’inesauribile, e purtroppo inesausta ed inevasa, fame di affetto che ci avvolge e ci divora, tanto più quando le circostanze ci creano intorno dei muri.
In tutto questo il vocio della radio, lo squillo del telefono, le invisibili presenze circostanti, l’incontro comunque nevrotico che in Jennifer avviene con una vicina di casa ( che qui significativamente è donna, ma in Ruccello è anch’essa un travestito) sono il ronzio speculare del turbine che si agita nell’animo dei personaggi, che cercano, in entrambe le opere, una ragione per non togliersi la vita, e non sempre ci riescono.
In alcuni momenti, come si vede, con de Rosa entriamo nel cuore dell’anima del teatro moderno, quello che privilegia il significante sul significato o la destrutturazione del testo nella scrittura di scena vissuta dall’attore. Ma De Rosa non si lascia avvolgere dagli schemi. La scelta espressiva è dettata dal suo essere animale di scena ora tragicomico ora comitragico,
Ed è qui il suo fascino, perché in questa compiutezza egli diverte, coinvolge, commuove, emoziona. E fa esplodere la vita anche a contatto con la morte. Ed in quel riso fatto di pianto si sente personaggio-persona tra persone, ci fa sentire persone con una persona e ci fa piangere ridendo.
Ma le lacrime alla fine sono come tergicristalli, che puliscono gli occhi per vederci meglio …
Le storie delle quattro figure sembrano ritagliare persone della vita quotidiana. Ruccello stesso, infatti, scrive: “Tendo molto a costruire per linguaggi anche i personaggi. Spesso individuo prima un modo di parlare e poi intorno a quello costruisco il personaggio vero e proprio. Alla fine mi accorgo di aver riprodotto delle stereotipie verbali che sono del mio ambiente, di mio padre, di mia cugina, pur cercando di evitare, come massimo dei mali, di far autobiografia a teatro. Finisco comunque per raccontare il mio ambiente”. L’ambiente, al quale il Commediografo si riferisce, è quello della provincia di Napoli, soprattutto di Castellammare di Stabia.
In realtà si tratta, a mio avviso, – e in questo adattamento ho inteso evidenziarlo – di figure “ingabbiate” in una realtà ad esse estranea. Ogni personaggio nasconde un disagio, un malessere, un’ossessione, un’ansia verso il mondo esterno, e ognuno di tali personaggi oscilla tra la consapevolezza e l’incoscienza, tra la ragione e la follia, tra il gioco e il mistero.
Qual è il mezzo per evadere da tale “estranea” realtà? E’ il sogno. Il sogno-desiderio di poter essere, di poter apparire e di potersi autorappresentare; di poter diventare una delle tante icone televisive o delle innumerevoli telenovelas verso cui si protende. E così realtà e finzione diventano un tutt’uno confondendo ed esagitando sempre di più gli animi.
A rimettere il tutto a posto sarà una sorta di “deus ex-machina” che, nel bene o nel male, scuoterà il vissuto dei vari personaggi.
Le storie delle quattro figure sembrano ritagliare persone della vita quotidiana. Ruccello stesso, infatti, scrive: “Tendo molto a costruire per linguaggi anche i personaggi. Spesso individuo prima un modo di parlare e poi intorno a quello costruisco il personaggio vero e proprio. Alla fine mi accorgo di aver riprodotto delle stereotipie verbali che sono del mio ambiente, di mio padre, di mia cugina, pur cercando di evitare, come massimo dei mali, di far autobiografia a teatro. Finisco comunque per raccontare il mio ambiente”. L’ambiente, al quale il Commediografo si riferisce, è quello della provincia di Napoli, soprattutto di Castellammare di Stabia.
In realtà si tratta, a mio avviso, – e in questo adattamento ho inteso evidenziarlo – di figure “ingabbiate” in una realtà ad esse estranea. Ogni personaggio nasconde un disagio, un malessere, un’ossessione, un’ansia verso il mondo esterno, e ognuno di tali personaggi oscilla tra la consapevolezza e l’incoscienza, tra la ragione e la follia, tra il gioco e il mistero.
Qual è il mezzo per evadere da tale “estranea” realtà? E’ il sogno. Il sogno-desiderio di poter essere, di poter apparire e di potersi autorappresentare; di poter diventare una delle tante icone televisive o delle innumerevoli telenovelas verso cui si protende. E così realtà e finzione diventano un tutt’uno confondendo ed esagitando sempre di più gli animi.
A rimettere il tutto a posto sarà una sorta di “deus ex-machina” che, nel bene o nel male, scuoterà il vissuto dei vari personaggi.Le storie delle quattro figure sembrano ritagliare persone della vita quotidiana. Ruccello stesso, infatti, scrive: “Tendo molto a costruire per linguaggi anche i personaggi. Spesso individuo prima un modo di parlare e poi intorno a quello costruisco il personaggio vero e proprio. Alla fine mi accorgo di aver riprodotto delle stereotipie verbali che sono del mio ambiente, di mio padre, di mia cugina, pur cercando di evitare, come massimo dei mali, di far autobiografia a teatro. Finisco comunque per raccontare il mio ambiente”. L’ambiente, al quale il Commediografo si riferisce, è quello della provincia di Napoli, soprattutto di Castellammare di Stabia.
In realtà si tratta, a mio avviso, – e in questo adattamento ho inteso evidenziarlo – di figure “ingabbiate” in una realtà ad esse estranea. Ogni personaggio nasconde un disagio, un malessere, un’ossessione, un’ansia verso il mondo esterno, e ognuno di tali personaggi oscilla tra la consapevolezza e l’incoscienza, tra la ragione e la follia, tra il gioco e il mistero.
Qual è il mezzo per evadere da tale “estranea” realtà? E’ il sogno. Il sogno-desiderio di poter essere, di poter apparire e di potersi autorappresentare; di poter diventare una delle tante icone televisive o delle innumerevoli telenovelas verso cui si protende. E così realtà e finzione diventano un tutt’uno confondendo ed esagitando sempre di più gli animi.
A rimettere il tutto a posto sarà una sorta di “deus ex-machina” che, nel bene o nel male, scuoterà il vissuto dei vari personaggi.