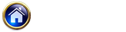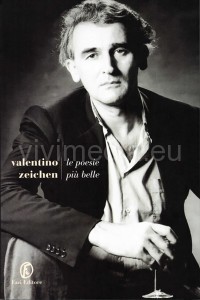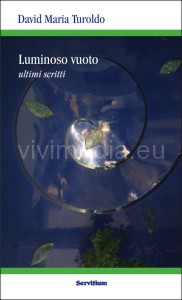Archivio
ricerca per autore
Un anno fa moriva Valentino Zeichen. Poeta “marziale” e tifoso laziale. Fazi Editore ne ricorda l’anniversario pubblicando le poesie più belle
Un anno fa moriva Valentino Zeichen. Poeta che si tenne sempre ben lontano da facili riflettori che spesso abbagliano anche scrittori e uomini di cultura, preferendo una scelta di vita “tutta sua” esplicitata così bene da queste parole di Valerio Magrelli: “sdegnoso rifiuto di un qualsivoglia lavoro con violenti attacchi alla civiltà dei consumi”. Non ho mai conosciuto Zeichen se non attraverso le sue poesie. Il poeta, originario di Fiume, in seguito dell’esodo del popolo istriano, aveva seguito, orfano della madre, il padre a Roma, città in cui vivrà per tutto il corso della sua vita in un’abitazione assai umile sulla via Flaminia, la cosiddetta “casa/baracca” che il suo amico e poeta Dario Bellezza chiamava “la topaia”. Avrei avuto anche diverse occasioni per incontrarlo personalmente, ma una strana ritrosia che non saprei spiegare nemmeno a me stesso, me l’ha sempre impedito: forse mi sembrava che era più giusto “addentrarsi” nelle sue poesie “lasciando in pace” l’uomo alla sua intimità. La stessa cosa che ho sempre pensato di Sandro Penna: poeta singolare e voce importante del nostro Novecento, la cui vita privata, se non “riversata” nei suoi versi, era giusto che restasse privata. Sapevo che Zeichen era un grande appassionato di calcio e tifosissimo della Lazio e così pianificando la struttura del mio libro Calcio d’autore, decisi di inserirvi anche una sua poesia: “ A Bruno Giordano”. Giordano, centravanti, alcuni anni fa, della Lazio e non solo, nei versi di Zeichen, veste gli abiti di un antico grande gladiatore. La folla lo acclama ancor più dell’imperatore. Il poeta con leggiadra ironia, nel segno di Marziale, come ebbe a rilevare Moravia, sferza la tanto detestata società odierna infarcita di falsi miti, di nuove laiche divinità.
A Bruno Giordano
Un remoto LAZIO-JUVENTUS; tre a zero
esplode l’anonimo urlo di trionfo,
sì; ma chi ha recapitato al presente
il nome di quel gladiatore: Bruno Giordano
che si distinse durante i giochi
per l’incoronazione dei titoli di Augusto;
con quale punteggio sconfisse le fiere zebrate
se l’ovazione riservatagli dalla folla
superò i cento decibel, sopravanzando
quella resa di consueto all’imperatore?
(da Antonio Donadio Calcio d’autore. Da Umberto Saba a Gianni Brera: il football degli scrittori. Editrice La Scuola, 2016)
Ma a ben guardare Zeichen fu anche una sorta di poeta che, in alcuni casi, definirei “nascostamente lirico”. Un esempio può ritrovarsi nei versi che seguono caratterizzati da accenti lirici: versi in cui, seppur connotati da una poetica fortemente argomentativa, non secondario emerge un certo “respiro lirico”: “Come dirti ancora amore mio,/ mia, mio, adesso/ che gli aggettivi possessivi/ sono istruiti di dubbi, svogliati/ e disaffezionati alla proprietà/ abbandonano la guardia e disertano/ lasciando sguarniti i beni privati,/ concedendosi solo al plurale.” Splendido l’inizio: “Come dirti ancora amore mio,/ mia, mio, adesso” laddove il secondo verso rafforza il possesso che è proprio dell’Amore e degli amanti nell’eterno sogno dell’ hic et nunc. E’ un lirismo velato che ci mostra il poeta Zeichen che ancora “marzialmente” ammonisce, ma dove, con sofferta tristezza, sottolinea che persino in amore vengono “sguarniti i beni privati” permettendo al singolo uomo – a ognuno di noi – l’amara possibilità di concedersi “solo al plurale”.
Valentino Zeichen (Fiume 1938 -Roma 2016). Tra i libri di poesie ma anche di romanzi, citiamo: Area di rigore (1974); Ricreazione (1979); Museo interiore (1987); Neomarziale (2006); Passeggiate romane (2004); Casa di rieducazione (2011; ) La sumera (2015). Tutte le sue poesie, nel 2004, sono state pubblicate negli Oscar Mondadori con prefazione di Giulio Ferroni.
Lo scorso mese di luglio in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, è stato pubblicato: Valentino Zeichen Le poesie più belle – Fazi Editore. Il libro si apre con un inedito del 2010 per il matrimonio tra Elido Fazi e Alice Di Stefano. Altri due inediti nell’ultima sezione.
Trieste: la città di Saba ma anche di Sergio Penco
Trieste e Saba sono legati indissolubilmente. Non si può pensare al grande poeta senza pensare alla splendida città. Eppure c’è anche un altro poeta, triestino come Saba, che merita non solo un ricordo, ma anche un’attenzione particolare, non ricevuta, forse, adeguatamente in vita: Sergio Penco. Di lui ho scelto la poesia “L’osteria” che, secondo me, esemplifica molto dell’uomo e del poeta.
L’osteria
Un gabbiano che piani per caso dentro un’osteria
sospinto dal vento e dai cattivi pensieri
non può fare altro che bere del vino rosso
e unirsi alla bella compagnia
in sarabanda di bestemmie e di ammiccamenti e giochi d’azzardo,
girando invano lo sguardo
dagli angoli più celati a sotto i tavolini,
dove ristagnano macchie d’unto e di muffa
e polvere e facchini.
Eppure si sa che fuori dall’uscio, oltre le case grigie,
oltre la nebbia, oltre l’odore di ruggine,
aspro brulica il mare,
ma non è il caso di sbattere forte le ali
né di gemere come la pioggia che si uccide sui tetti,
nel riluttante spegnersi del giorno
è più opportuno fingersi uguali
al gatto, e fare le fusa, e sonnecchiare.
Dalle panche dell’osteria non si fa ritorno
ma il fumo dell’osteria raggiunge la luna.
(da “Ballata dal Mary Celeste” Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, 1998)
L’osteria, dove un gabbiano è planato per puro caso, diventa il luogo dell’esistere, dello stare. Lo sventurato uccello si ritrova, così, in un posto a lui non naturale sospinto da una forza fuori di sé e da una forza dentro di sé, entrambe incontrollabili (“sospinto dal vento e dai cattivi pensieri”). Palese riferimento a L’albatros di Baudelaire catturato dai marinai e posato sulla tolda, “que ces rois de l’azur”. L’osteria è un’osteria, e come tale, luogo destinato all’illusorio star bene nel bere vino in godibile e bella compagnia, ma tutt’intorno “girando invano lo sguardo” (il movimento dell’atto del guardare è reso da Penco attraverso un gioco iterativo in rima al mezzo del gruppo consonantico in a e o: girando invano lo sguardo), la realtà è ben altra cosa, celata agli occhi degli avventori: “macchie d’unto e di muffa / e polvere”. Ecco il luogo in cui è costretto a vivere un gabbiano, nato per il cielo e per il mare. E’ fuori il luogo dove poter essere realmente se stesso; fuori da quell’uscio “oltre le case grigie,/oltre la nebbia, oltre l’odore di ruggine”, fuori è il regno della piena libertà, del volo libero. Ad aspettare i suoi voli, “aspro brulica il mare”. E’ questo verso, il cuore dell’intera poesia. Ma sarebbe retorica decadente inneggiare a un luogo fatto di serenità e quiete da contrapporsi all’osteria. Infatti ad attendere i voli del gabbiano, ecco un mare brulicante di vita, di mille esseri viventi e pensanti, ma nello stesso tempo un mare per nulla rassicurante, impetuoso, duro, severo, (“aspro brulica”), ma anche fiero. Metafora della vita non rassicurante ma viva e fatta di uomini che non distraggono menti e pensieri nell’illusorio consolatorio calice di vino rosso d’osteria. Eppure il gabbiano è lì, chiuso tra quattro pareti, le sue ali son chiuse; nulla varrebbe sbatterle frementi per un impossibile volo. Sarebbe solo un suicidarsi proprio come fa la pioggia che nata dal cielo e per il cielo, gemendo, sceglie di lasciarsi morire sui tetti: “come la pioggia che si uccide sui tetti”. Quale possibilità, quindi per il gabbiano/uomo? Lasciarsi vivere, accettare a male in cuore un ritmo di vita scelto da altri, uniformarsi alla loro vita, fingersi uguali tacendo l’urlo della diversità, vivere da gatto d’osteria: “fare le fusa, e sonnecchiare”. E’ la scelta per la sopravvivenza! Triste accettazione di una condizione di vita esistenziale. Ma la ballata non finisce qua: si chiude con un distico dal respiro aforistico: “Dalle panche dell’osteria non si fa ritorno/ ma il fumo dell’osteria raggiunge la luna”. Un velato incoraggiamento del poeta: se è pur vero che da “una vita d’osteria” non si esce immuni, “non si fa ritorno”, sappia l’uomo che non è solo pensiero, non solo realtà temporale limitata, ma anche sogno, fantasia, speranza: regni certamente inesistenti e impalpabili proprio come “fumo” che si alza dal nostro vivere di osteria, ma libero proprio come un volo di gabbiano che può raggiungere il cielo e volare molto alto, fino alla luna.
Sergio Penco (Trieste 1943- 2009). Poeta raffinato e assai riservato amò essere lontano dai “salotti letterari” (o pseudo tali). Tra le sue raccolte di versi ricordiamo “Guadalajara” , Rebellato Editore , 1978; “Ballata dal Mary Celeste” Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, 1998; “Ballate di Cane Nero”, Sciascia Editore,2002; “Con una rosa dei Venti tra i denti” ,Hammerle Editori, 2009. Tradotto in inglese, francese e sloveno, collaborò con testate giornalistiche locali firmando anche diverse trasmissioni radiofoniche per la sede regionale Rai. Nel 2009 è uscito postumo, in edizione limitata di 250 copie, il libro “Poesie inedite”, Franco Rosso Editoree lo scorso anno”Poesie”, Libreria Editrice San Marco.
Per una nuova stagionatura degli uomini nei versi di Giancarlo Zizola
 Alla ricerca di un filo che annodi l’uomo, tormentato, dubbioso, impaurito, svogliatamente spavaldo, col taciuto desiderio di un mondo mitico per una mitologia dell’uomo lungamente e ininterrottamente sognato, giammai fantastico solo terribilmente umano, ecco la sognata renovatio, in quest’ultimo libro di Carlo G. Zizola (La neve e il tempo Casa Editrice el squero, Venezia, 2016). Una nuova Alba: “ L’alba apre squarci azzurri/per una nuova stagionatura degli uomini”. Il vivere presente non è che “dimora provvisoria” laddove “ i lampioni frugano/ come volessero portare in superficie/ un groviglio di cose incerte” (Dal vento che accarezza le colline). La scrittura di Zizola è scrittura matura, non regala nulla allo scontato, all’effetto, al coup de théâtre. Esigenza che viene dal profondo, dall’inconoscibile, dal misterioso magma che è proprio del ποιείν.Tutto si fa verso, la natura con le sue creature inanimate e animate e tra di esse l’uomo, mai artifex, mai giudice del suo destino, ma solo eterno viandante segnato dal perenne interrogarsi del suo cammino, del nostro cammino di uomini. Ma non è solo: “ e il cuore s’abbandona/a una strana selva/di gnomi e fate incorniciata/dal cristallo definitivo della luna” (Un bosco magico). Versi caratterizzati, a volte, persino da una vigoria gnomica. Il ritmo, nella mal celata veste prosastica, accompagna i versi dondolando immagini su immagini dove il lettore (se non è distratto) si lascia andare.
Alla ricerca di un filo che annodi l’uomo, tormentato, dubbioso, impaurito, svogliatamente spavaldo, col taciuto desiderio di un mondo mitico per una mitologia dell’uomo lungamente e ininterrottamente sognato, giammai fantastico solo terribilmente umano, ecco la sognata renovatio, in quest’ultimo libro di Carlo G. Zizola (La neve e il tempo Casa Editrice el squero, Venezia, 2016). Una nuova Alba: “ L’alba apre squarci azzurri/per una nuova stagionatura degli uomini”. Il vivere presente non è che “dimora provvisoria” laddove “ i lampioni frugano/ come volessero portare in superficie/ un groviglio di cose incerte” (Dal vento che accarezza le colline). La scrittura di Zizola è scrittura matura, non regala nulla allo scontato, all’effetto, al coup de théâtre. Esigenza che viene dal profondo, dall’inconoscibile, dal misterioso magma che è proprio del ποιείν.Tutto si fa verso, la natura con le sue creature inanimate e animate e tra di esse l’uomo, mai artifex, mai giudice del suo destino, ma solo eterno viandante segnato dal perenne interrogarsi del suo cammino, del nostro cammino di uomini. Ma non è solo: “ e il cuore s’abbandona/a una strana selva/di gnomi e fate incorniciata/dal cristallo definitivo della luna” (Un bosco magico). Versi caratterizzati, a volte, persino da una vigoria gnomica. Il ritmo, nella mal celata veste prosastica, accompagna i versi dondolando immagini su immagini dove il lettore (se non è distratto) si lascia andare.
L’alba
Tra nuvole aureola di Dio
l’alba apre squarci azzurri
per una nuova stagionatura degli uomini,
ingravida il tempo l’attesa, illumina
bivacchi notturni e un silenzio eccitato
dal bagliore dei primi eventi.
Inevitabilmente, il giorno rotola
verso domande imbarazzanti,
strade bagnate e cortili sommersi
dai mozziconi delle nostre abitudini
motori arrugginiti e pensieri senza logica;
qualcuno, ancora carico d’ombra
chiede al primo sconosciuto che incontra,
come se avesse la risposta in faccia,
se capire ciò che sta nel cuore
sia cosa semplice.
Carlo G. Zizola (Giancarlo) è nato ad Asolo (Treviso) dove vive. Laureato in sociologia, da molti anni si occupa d’importanti eventi culturali. Tra le sue pubblicazioni in versi più recenti: “Per le strade” Edizioni del Leone, 2004; “Vortici” Edizioni del Leone, 2007 e il romanzo “Quando l’amore odia” Campanotto Editore, 2016. E’ in via di pubblicazione un prossimo libro di poesie.
Venticinque anni fa moriva Padre Turoldo. In “Luminoso vuoto” le sue ultime poesie i suoi ultimi scritti
“[…] Descriver tutte le parti dolenti? Tutte le fasi di spasimo? Impossibile; e per di più imprevedibili. Sarà necessario abituarsi: come si faccia Dio solo lo sa. Non pensare, fingere di non pensare, di non sentire. Ad esempio, non è che mi sia assente la paura di impazzire. E’ così, ormai da mesi. Signore, abbi pietà di me”. Terribile e al tempo stesso meravigliosa testimonianza di cosa sia il dolore fisico, e non solo, in questo scritto ultimo di Padre Davide Maria Turoldo (morirà di cancro, pochi giorni dopo, nel febbraio del 1992). Raccolto e conservato gelosamente dall’amico e confratello padre Camillo de Piaz che così annota: “ Scritto una settimana prima di morire. Per se stesso”. E oggi pubblicato in un elegante volumetto (Davide Maria Turoldo Luminoso vuoto- Ultimi scritti Premessa, postfazione e antologia critica a cura di Giorgio Luzzi, Servitium Editrice (MI), 2016 pagine144, Euro 12,00). Si rende omaggio a Turoldo in occasione del centenario della nascita (1916/2016) e del venticinquesimo della scomparsa. Dirompenti questi ultimissimi suoi versi:
Gli altri scrivono di “altopiani”,
in forme stupende,
parlano con tutti…
sanno tutte le malizie della mente
le sante malizie,
sono dentro il grande fiume delle lettere,
del discorso umano:
e sono certo che hanno ragione.
Ma io non riesco, non riesco,
sono un maniaco di Dio.
E’ come se avessi la fronte un chiodo…
Turoldo, quindi, “maniaco di Dio”, ma non solo: “… egli era anche non molto meno, un maniaco del verso, del suono, del ritmo, una forte e assolutamente paritetica mano che batta sulla pelle del proprio tamburo a mandare segnali scivolanti, orizzontali, agli altri abitatori dell’altopiano a metterli in comunicazione tra loro”. (Luzzi). “Mettere in comunicazione gli abitatori dell’altopiano”, quasi un epitaffio dell’intera esistenza di quest’uomo, padre dei Servi di Maria e poeta. Ma chi è Padre Davide Maria Turoldo, nato in un paesino friulano (Coderno) il 22 novembre 1916 battezzato col nome di Giuseppe e per gli amici “Bepi il rosso” per via della fulva capigliatura? Un uomo robusto dagli occhi penetranti e dalla parola vigorosa, come pietra; combattivo, forte, pugnace. Originalissimo poeta, ma soprattutto prete “scomodo”: la scelta coraggiosa e difficile di prender parte personalmente alla Resistenza e poi scomodo per le sue improvvide (per taluni) omelie dal pulpito del Duomo della Milano degli anni ’60 che non gli risparmiò critiche feroci e attacchi violenti. Attacchi che non ebbero mai veramente fine. In Turoldo l’uomo e il poeta si fondono, sono tutt’uno. La sete dell’apostolato è sete costante, i suoi versi come semina, germinazione sicura. Non può, non sa trattenersi: è la luce della Fede che lo illumina verso un cammino che sa che non può essere altro che quello indicato dal Signore. Tutto ciò afferisce alla sfera teologico – metafisica: visione ed esperienza piena di Dio che non annienta la nostra personalità, ma la potenzia al grado supremo. Uomo tra gli uomini, sempre. Questo libro curato da Giorgio Luzzi non ci restituisce solo il Turoldo che conosciamo, attraverso un inedito mannello di “meditazioni liriche” e scritti in prosa oltre a un’ importante mini antologia di scritti critici a firma di importanti poeti e critici tra cui Ungaretti, Fortini, Giudici, Luzi, Porta, Zanzotto e ancora Bo, Guarracino, Ramat, ma anche un singolare, inaspettato scritto dal sapore di confessione. Turoldo, un mese prima di morire, sente il bisogno, l’urgenza di confessare, si potrebbe dire, “un peccato di gioventù”: aver dedicato una poesia a Mussolini. Si era nel 1934 e il poeta aveva solo diciotto anni. Scrive: “Ebbene, amici, cedo e rilascio per iscritto anche questo ricordo. Ce l’ho qui, da sempre, nella mente come una lucida ferita. Ero nato troppo presto per non subire; e il tempo della Libertà è venuto troppo tardi. Da ricordare che stavo ostaggio in seminario, e perciò non finirò mai di scusarmi e di confidare nel perdono. Per fortuna che, dopo, appena uscito e giunto a Milano, è cominciata subito l’altra storia: questa, che sto ancora vivendo. Dunque, anch’io ho cantato al Duce”. A seguire una breve lirica di diciassette versi. Turoldo chiede di essere perdonato. E Luzzi così scrive: “E’ la sua lucida ferita” tenuta segreta, almeno nel suo significato più profondo, per un’esistenza intera. […] …Vai in pace, David, noi tutti ti assolviamo, i tuoi versi all’”Uomo” sono persino belli”.